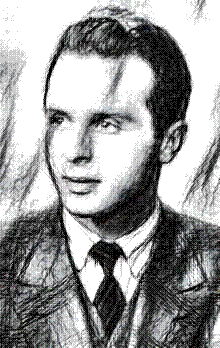
Il contesto
San Giovanni in Persiceto, a cavallo tra anni Quaranta e Cinquanta del secolo scorso, costituiva il terzo centro della provincia di Bologna, dopo il capoluogo e Imola.
In quel periodo il paese assisteva a un significativo calo demografico essendo penalizzato dalla lontananza dal capoluogo e dall’esodo dalle campagne.
Pur non essendo considerabile tra le terre più povere, San Giovanni registrava indici elevati di arretratezza con una campagna priva di risorse sufficienti a dare lavoro a un numero elevato di braccianti.
La produzione era caratterizzata, a fianco del grano, da colture in declino, come canapai e risaie, che si erano sviluppate a seguito delle bonifiche dei secoli e dei decenni precedenti e che vedevano grandi aziende agrarie che ricorrevano a lavoratori e lavoratrici stagionali.
A breve le risaie e i canapai sarebbero stati sostituiti da colture con minore richiesta di manodopera come barbabietola e alberi da frutto, fatto che avrebbe portato progressivamente alla diminuzione e poi alla scomparsa del bracciantato.
Il delitto che culminò con l’assassinio di Giuseppe Fanin, ventiquattrenne sindacalista cattolico della Libera Cgil, fu compiuto da parte di tre braccianti comunisti la sera del 4 novembre 1948 e avvenne proprio durante questa transizione nella società e nell’economia del paese del bolognese.
Va ricordato che ad esacerbare gli animi di un anno turbolento vi fu certamente l’attentato a Palmiro Togliatti del 14 luglio del 1948 quando l’estremista di destra Antonio Pallante colpì con tre colpi il leader comunista con un’azione che ne avrebbe potuto compromettere la vita.
È noto che le manifestazioni popolari e gli scioperi politici ad oltranza che ne seguirono portarono la corrente cristiana guidata da Giulio Pastore ad uscire, il 16 luglio, dalla Cgil unitaria.
L’organizzazione che, tra mille difficoltà e tensioni, stava nascendo sarà, come noto, denominata Libera Cgil e nascerà d’intesa tra la corrente cristiana e le Acli, pur cominciando gradualmente a superare il proprio assetto confessionale. Fanin fu un protagonista a livello locale di questi avvenimenti.
Il fratello Giorgio e l’onorevole democristiano Giovanni Bersani ricordarono il suo impegno attivo, iniziato almeno dal 1946 e sviluppatosi, in un primo momento, nelle Acli-terra[1].
La zona di San Giovanni in Persiceto aveva dato vita a una lunga tradizione di lotte agrarie in particolare nel primo Dopoguerra e a una significativa opposizione al fascismo.
Rispetto all’assassinio del giovane sindacalista è importante ricordare che il regime aveva abolito non solo le libere organizzazioni sindacali, ma anche il controllo sul reclutamento dei lavoratori (collocamento) che avevano, pur per breve tempo, conquistato.
Ai braccianti, durante il fascismo, era di solito concesso solo un terzo del raccolto (la c.d. “terzieria”).
Come ha rilevato Alberto Preti nell’introduzione al volume dedicato al delitto Fanin di Giuseppe Trevisi: “uno degli aspetti della vicenda nella quale matura il delitto Fanin è dunque la riproposizione, da parte del sindacalismo cattolico, nel secondo dopoguerra, del contratto di compartecipazione individuale come alternativa alla ribadita e accentuata connotazione di classe dei braccianti legati alla Confederterra e all’acuirsi della conflittualità delle campagne”[2].
Il tema della compartecipazione individuale fu oggetto, pertanto, di dispute tra chi considerava lo strumento come parte di un più ampio piano antilavoratori, e chi, come i sindacalisti della Libera Cgil, ma anche del sindacato socialdemocratico Fil, stipulavano contratti ben più favorevoli ai lavoratori della “terzeria” in uso durante il fascismo, riconoscendo ai lavoratori tra il 40 e il 45% dei prodotti agricoli.
È certamente vero che, nel 1948, c’era un certo scetticismo dei lavoratori, memori dell’esperienza sotto il fascismo, rispetto alla compartecipazione individuale, ma, come testimoniato dal fratello di Giuseppe, Giorgio Fanin, la propaganda del giovane ingegniere agrario (la laurea era il titolo di studio del giovane sindacalista) per la diffusione di un più favorevole rapporto compartecipativo stava creando consenso tra i braccianti ed è corretto riconoscervi il movente principale dell’omicidio.
Ci troviamo, è bene ricordarlo nuovamente, nel mezzo della lunga battaglia per il collocamento successiva alle elezioni dell’aprile del 1948 e poi della scissione sindacale, avvenuta in seguito allo sciopero generale proclamato a causa dell’attentato al leader del Partito Comunista Italiano Palmiro Togliatti.
Il controllo del collocamento, conquistato dal sindacato, in alcune regioni, con la caduta del fascismo rappresentava uno dei temi del contendere di quegli anni, cui si contrapponeva il progetto del collocamento di stato, anche per sottrarre al sindacato di classe uno strumento rilevante di condizionamento del mercato del lavoro.
Ha sottolineato sempre Alberto Preti:
“La contemporaneità della scissione sindacale e della nascita della Libera Cgil rende assolutamente drammatici i termini dello scontro, fra il 1948 e il 1949. Nel linguaggio usato dagli stessi dirigenti provinciali della Confederterra si alternano esortazioni a discutere con gli “scissionisti” ed incitamenti alla lotta che non escludono il ricorso ad altre armi e dunque a forme di contrapposizione violenta. Fu quello, a ben vedere, il momento più difficile della complessa partita per la democrazia giocata nel dopoguerra.
I vincitori politici del 1948 rilanciavano, in piena autonomia – e non senza contrasti nell’articolato universo cattolico e in particolare con i ceti proprietari – la propria concezione sindacale e cooperativa, fondata sulla valorizzazione della persona del lavoratore e su un riformismo solidale, teso a superare, insieme con la rigidità della contrapposizione di classe, sia la figura del bracciante che, in prospettiva, quella del mezzadro, per un pieno accesso dei contadini alla proprietà della terra lavorata[3] ”.
Chi era Giuseppe Fanin
Giuseppe Fanin, figlio di coltivatori diretti di origine vicentina, era nato l’8 gennaio del 1924 a San Giovanni in Persiceto, dove la famiglia si era trasferita nel 1910, acquistando un terreno[4].
Terzo di dieci figli, dopo periodo in seminario, vissuto tra il 1934 e il 1936, si ritirò, laureandosi successivamente in Agraria presso l’Università di Bologna, unico della famiglia a proseguire gli studi.
Fortemente impegnato nelle lotte sindacali agrarie del secondo dopoguerra, prima quale segretario provinciale bolognese delle Acli-terra e poi come esponente della Libera Cgil, Fanin, che stava creando una forte adesione attorno al nuovo sindacato in un’area di tradizionale insediamento comunista, era stato anche militante della Fuci, della quale aveva fondato una sezione a San Giovanni in Persiceto.
Un delitto atroce, una follia orribile
21.40, 4 novembre 1948…
“l’uomo nell’ombra (…) lo vide attraversare il ponte, dirigersi sulla Biancolina e lo seguì a breve distanza (…)
Chi è lei?
Fanin, perché?
La risposta che s’abbatté sul volto levato fu un colpo di sbarra che spezzò la mano alzata istintivamente in difesa e lacerò la fronte (…)
Raggiuntolo di nuovo, l’uomo dalla sbarra lo colpì al capo (…).
Una follia orribile, bestiale, travolse allora gli assassini. Mentre due lo percuotevano con calci e pugni, l’altro, con violenza selvaggia, continuò a picchiare sul capo spezzando le ossa, penetrando nel cervello, tre, quattro, cinque volte (…) Quanto la tremenda follia fu placata, gettò la sbarra oltre la siepe e insieme ai complici si dileguò nel buio.”[5]
Continua la ricostruzione Giuseppe Trevisi:
“Non morì subito. Un passante, che inizialmente lo aveva preso per ubriaco, diede l’allarme alla stazione dei carabinieri di Persiceto, i quali lo portarono all’ospedale.
Dovevano essere circa le 22 e 45. Il 5 novembre, all’1.45 il terribile rantolo che giungeva anche nel corridoio dove la fidanzata attendeva tremante, si affievolì e tacque”[6].
Ai funerali del giovane, il 7 novembre, parteciparono circa diecimila persone.
Le indagini e il processo
A seguito del delitto, con decreto prefettizio che conteneva l’accusa di non aver saputo gestire l’ordine pubblico, sarà sospeso dalla carica il sindaco di Persiceto, il comunista Giuseppe Drusiani.
Uno degli atti imputati a Drusiani fu quello di aver autorizzato l’affissione, a fine ottobre del 1948, di un manifesto in cui: “si additavano al pubblico disprezzo dirigenti dei sindacati liberi”.
Il manifesto, che recava l’intestazione della Camera del Lavoro e della Lega dei Braccianti, conteneva, tra l’altro, questi insulti:
(…) Lavoratori dei campi e delle officine!
La mano ossuta degli agrari, appoggiata dagli organi di governo, stretta a quella dei servi sciocchi tipo Fanin, Bertuzzi e Ottani, tenta di stendersi di nuovo rapace nelle nostre campagne per dividere i lavoratori e instaurare un regime di sfruttamento e di oppressione poliziesca di tipo fascista (…) [7].
Vi fu, già il 5 novembre, una prima tornata di fermi e di arresti, tra cui il segretario della Camera del Lavoro Eutimio Gasperini, il capolega dei braccianti Natale Scagliarini, ma anche Gino Bonfiglioli, lavoratore della canapa e segretario di sezione del Pci.
Il giorno 11 venne ritrovata l’arma del delitto, un’asta di ferro lunga circa 40 centimetri.
Nel frattempo si tenne a Molinella il convegno delle Acli che era slittato di una settimana proprio per l’uccisione di Fanin, al quale egli stesso avrebbe dovuto intervenire proprio con una relazione sul contratto di compartecipazione.
Su questo tema, per molti il vero movente del delitto, è stato scritto sul sindacalista ucciso:
“(…) Ma un problema soprattutto lo appassionò: il problema dei contratti agrari e in particolare quello della compartecipazione che egli vide inquadrato in un’azione positiva di emancipazione delle classi più diseredate dei lavoratori agricoli. Strappare questi dalla loro condizione di salariati e insieme da quella di organizzati nel chiuso sistema di collettivi di tipo sovietico: ecco l’idea guida del suo geniale lavoro”.[8]
La svolta delle indagini avvenne tra il 23 novembre e il 25 novembre. Furono quattro i fermati, tra cui tre braccianti comunisti: Aroldo Sighinolfi, Oliviero Azzani, Oplem Beghelli e, nuovamente arrestato dopo essere stato precedentemente fermato, Gino Bonfiglioli. Il 25 novembre, insieme al Bonfiglioli vennero arrestati i tre accusati di aver eseguito materialmente l’ordine: “di dare una lezione al Fanin” venuto da parte del segretario della sezione del Pci di San Giovanni in Persiceto: Indro Morisi, Enrico Morisi e Gian Enrico Lanzarini.
Fu proprio Gino Bonfiglioli a crollare e a confessare per primo il delitto.
Il processo per il delitto Fanin si svolse all’Aquila (per legittima suspicione) dal 15 al 22 novembre del 1949.
“In Fanin – affermò l’avvocato di parte civile Strazziari – si voleva sopprimere un terribile avversario e stroncare il primo affermarsi di un timido, ma già promettente libero sindacalismo”.
La sentenza confermò la natura della premeditazione dell’omicidio, pur con alcune attenuanti legate alle confessioni, e condannò Bonfiglioli e Lanzarini a 23 anni di carcere, Evangelisti e Morisi a 21 mentre Sighinolfi venne assolto per non aver commesso il fatto.
Il libro di Giuseppe Trevisi rileva un interessante passo delle parole indirizzate agli imputati dall’avvocato e onorevole democristiano Bettiol nel finale della sua arringa al processo dell’Aquila: “voi siete ricorsi al delitto per risolvere una lotta sindacale. E badate bene che per noi Fanin è un martire della libertà, da mettere accanto a Giacomo Matteotti ed a Bruno Buozzi[9]”.
La testimonianza viva di Giuseppe Fanin e il perdono della famiglia
A Giuseppe Fanin la Cisl ha voluto dedicare, deliberandolo nel giugno del 1959 ed inaugurandolo nel luglio dell’anno successivo, un padiglione del proprio Centro Studi Nazionale di Firenze. Come un destino della storia, il padiglione dove si formano i sindacalisti e le sindacaliste della confederazione si trova vicino proprio al padiglione dedicato a Bruno Buozzi.
Quella del sindacalista emiliano di origini venete è una storia, oggi troppo poco conosciuta, che colpisce soprattutto i sindacalisti più giovani, ormai lontanissimi temporalmente dalle vicende in cui maturò il suo assassinio.
Ha raccontato Giorgio Fanin, nell’agosto del 1997:
“Sono convinto che il motivo prevalente del delitto sia nel contratto di compartecipazione che mio fratello stava preparando e che avrebbe dovuto presentare al convegno di Molinella il 7 novembre.
Con quel tipo di contratto il bracciante diventava sempre più partecipe della produzione. L’innovazione di Giuseppe consisteva nell’aumento della quota di partecipazione, nell’aumento della percentuale spettante al lavoratore.
E questo dava fastidio, perché le quote proposte da mio fratello arrivavano anche al 40% per la produzione della canapa. Dava fastidio agli agrari, nei cui confronti si comportava con assoluto rigore e coerenza contrattuale, ma anche alla lega, alla Cgil, perché al posto della lotta di classe si indicava la collaborazione. Giuseppe stava lavorando sodo sul quel progetto, parlando con tutti, contattando i braccianti che cominciavano a capire. Sì, credo proprio che quella proposta sia stata come la goccia che fa traboccare il vaso. Con la sua morte quel progetto non ebbe più gambe per andare avanti e anche questo mi conferma nella mia convinzione sul motivo del suo assassinio”[10].
Il fratello di Giuseppe Fanin ha ricordato anche come venne donato il perdono agli assassini da parte della famiglia:
“Dieci anni dopo il processo venne a casa nostra il direttore del carcere, credo di Orvieto, a chiedere il perdono della famiglia. Mio padre Virgilio, rassicurato sul reale pentimento dei colpevoli, lo concesse e penso che questo abbia consentito loro di uscire anticipatamente. Lanzarini, poi, lo vidi qualche anno dopo che era uscito dal carcere a una festa della parrocchia di Tivoli e mi strinse la mano, ringraziandomi per il perdono. Ricordo benissimo che i presenti rimasero di sasso, esterrefatti ed impressionati”[11].
È stato giustamente detto che, nel giovane sindacalista, fede e impegno sociale erano aspetti assolutamente inscindibili[12].
Interrogato su questo punto Fanin, di fronte alle gravissime minacce, cui era stato fatto oggetto fin dall’estate del 1948, aveva risposto: “Se Dio mi chiederà la vita, non potrò negargliela”.
In occasione del settantesimo anniversario della morte la Diocesi di Bologna ha promosso un docufilm, intitolato: I migliori anni della nostra vita.
Ha sottolineato l’arcivescovo di Bologna, il cardinale Matteo Zuppi: “La vita di Fanin ci racconta di come egli fosse votato a trovare risposte e soluzioni progettuali. Esattamente quello di cui abbiamo bisogno adesso. La sua vicenda è un grande monito contro la violenza, l’intolleranza, l’ideologizzazione, l’idea del nemico; ci dice che non si tratta soltanto di un problema di controllo, ma di pratica del dialogo. Giuseppe Fanin, è stato un cristiano autentico, un uomo di preghiera che non può essere capito senza la fede. Ci testimonia che il problema del cristiano non è il potere, ma il servizio, il rifiuto dell’ingiustizia. La Fede, infatti, si traduce in attenzione all’altro. (…) [13]
È in corso il processo di beatificazione dello stesso Fanin (già riconosciuto: “servo di Dio”) che, recentemente, ha individuato la causa principale proprio nel suo martirio.
Giuseppe Fanin ci pone questo monito: perché ci opponiamo al bene?
Ci racconta, poi, di un entusiasmo instancabile per cambiare il mondo fino a morire per un ideale: quello del sindacato libero e della partecipazione dei lavoratori, a partire da quelli più umili, come i braccianti e i lavoratori della canapa.
A quasi ottanta anni dal suo estremo sacrificio non possiamo e non vogliamo dimenticarlo.
[1] Giuseppe Fanin, A.B.E.S, Bologna, 1949.
[2] G. Trevisi, Il delitto Fanin. 4 novembre 1948, Il Mulino/Alfa Tape, Bologna, 1998, pag. 11.
[3] G. Trevisi, Il delitto Fanin. 4 novembre 1948, Il Mulino/Alfa Tape, Bologna, 1998, pag. 14.
[4] Per una più estesa biografia di Giuseppe Fanin si vedano: A. Albertazzi, Fanin Giuseppe, in Dizionario storico del movimento cattolico in Italia 1860-1980, diretto da F. Trainello e G. Campanini, Casale Monferrato, III, 1984, pag. 348 e A. Albertazzi, Per Giuseppe Fanin. Documenti 1924-1948, Cappelli, Bologna, 1987.
[5] Giuseppe Fanin, A.B.E.S, Bologna, 1949, ricostruzione ipotetica, ma molto verosimile stante gli atti processuali.
[6] G. Trevisi, Il delitto Fanin. 4 novembre 1948, Il Mulino/Alfa Tape, Bologna, 1998, pag. 21.
[7] Giuseppe Fanin, A.B.E.S, Bologna, 1949, pag. 69.
[8] Giuseppe Fanin, A.B.E.S, Bologna, 1949, pagg. 48-49.
[9] G. Trevisi, Il delitto Fanin. 4 novembre 1948, Il Mulino/Alfa Tape, Bologna, 1998, pag. 150.
[10] G. Trevisi, Il delitto Fanin. 4 novembre 1948, Il Mulino/Alfa Tape, Bologna, 1998, pagg. 154-155.
[11] G. Trevisi, Il delitto Fanin. 4 novembre 1948, Il Mulino/Alfa Tape, Bologna, 1998, pag. 155.
[12] Si veda Tracce d’Infinito, Fanin dalla parte dei deboli, fino al martirio: https://www.youtube.com/watch?v=zgOhTiflpQI
[13] Si veda sempre Tracce d’Infinito, Fanin dalla parte dei deboli, fino al martirio: https://www.youtube.com/watch?v=zgOhTiflpQI

